
Il tutto in un contesto di palesi violazioni della normativa comunitaria sui rifiuti, come tra l’altro attesta la normativa nazionale sulla promozione delle energie prodotte da fonti rinnovabili (il cd. “affaire” cip6).
In questa sede si analizzeranno, brevemente, la disciplina e l’utilizzo degli strumenti finanziari (TARSU e TIA) in materia, la spinosa tematica del finanziamento delle energie rinnovabili, nonché le esperienze virtuose che hanno risolto il problema della gestione dei rifiuti con strumenti alternativi al circuito discariche-inceneritori.
L’azione comunitaria in materia di rifiuti, s’ispira in particolare ai principi di prevenzione, del “chi inquina paga” e di precauzione, ponendosi inoltre tre obiettivi fondamentali: prevenire la creazione di rifiuti migliorando la concezione dei prodotti, ridurre l’inquinamento provocato dall’incenerimento dei rifiuti, promuovere il riciclaggio e la riutilizzazione dei rifiuti. (1)
In ambito internazionale la Comunità è parte della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione (Convenzione di Basilea del 1994). Tale Convenzione si propone di ridurre il traffico dei rifiuti ed istituisce un sistema di controllo delle esportazioni e delle importazioni, stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi. Tra l’altro la Comunità ha ratificato un emendamento della Convenzione che vieta l’esportazione dei rifiuti pericolosi dai Paesi dell’OCSE, dell’UE e del Liechtenstein verso i Paesi non membri dell’OCSE. (2) Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nell’ordinamento interno, il D.Lgs 152/2006 (Codice dell’ambiente), prevede che l’attività di recupero e di smaltimento degli stessi, non debba costituire un pericolo per la salute umana, non debba essere fonte di rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, non debba causare inconvenienti per immissioni di odori o di rumori, non debba causare danni al paesaggio, salvaguardando in particolar modo quelle zone di particolare pregio ambientale, tutelate dall’ordinamento. Principi informatori dell’intera materia sono quelli di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilità, cooperazione dei vari enti coinvolti, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
La tematica dello smaltimento dei rifiuti ha spesso trovato una grossa eco sui media locali e nazionali. Specialmente in alcune realtà meridionali si è assistito ad una cronicizzazione dell’emergenza, con il ricorso a gestioni straordinarie, ingenti sprechi e l’opposizione delle popolazioni locali ad impianti come discariche ed inceneritori.
La Legge n. 366 del 1941 è la prima a considerare la natura di tributo del quantum dovuto a fronte del servizio di raccolta dei rifiuti. La normativa viene poi rivista con il D.P.R. n. 915 del 1982 il quale introduce la tassabilità delle aree scoperte. Ulteriori modifiche si hanno con la Legge n. 144 del 1989 che sancisce l’obbligo di coprire le spese del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti con i proventi della riscossione della stessa tassa.
Oggi la TARSU è regolata dal D.Lgs. n. 507 del 1993.
Presupposto d’applicazione della tassa non è la fruizione del servizio e, quindi, l’effettiva produzione di rifiuti ma la potenzialità a produrli, provocata dall’occupazione di locali o aree scoperte situate nel territorio comunale. (3)
Vi è dunque la presunzione di produzione di rifiuti a causa della detenzione, occupazione o il possesso dei locali o delle aree scoperte tranne naturalmente casi determinati da rendere noti all’Amministrazione comunale in fase di prima denuncia o variazione dal contribuente(4).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che il presupposto della tassa è la detenzione dei locali o delle aree e non dell’attività che vi si svolge.
L’attività, insieme alla superficie è soltanto un parametro a cui commisurare la tassa. Dunque, solo i locali oggettivamente inutilizzabili ne sono esclusi; si tratta di quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato d’abbandono. Il regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti prevede la classificazione delle categorie dei locali e delle aree che hanno caratteristiche tali da essere considerate omogeneamente tassabili, le tariffe ridotte per casi determinati, nonché le fattispecie agevolate e le relative modalità di trattazione. Sono soggetti passivi della TARSU unicamente coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte soggette alla tassa e comunque, sono solidalmente obbligati i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune gli stessi locali. Esiste, infatti, il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.(5) Escluse dalla tassazione sono le aree comuni del condominio(6), tuttavia l’obbligazione grava su tutti coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento è invece il soggetto che gestisce i servizi comuni per tutti i locali di uso comune e per quelli utilizzati in via esclusiva da singoli occupanti o detentori. Per questi ultimi soggetti persistono comunque gli obblighi o i diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. E’ ovvio che i locali destinati ad essere utilizzati come solai e cantine (attesa l’incapacità di produrre rifiuti, stante il mancato collegamento della vita del contribuente con l’uso degli stessi locali) non sono soggetti alla TARSU, a meno di specifiche e diverse situazioni che il Comune ha comunque l’onere di dimostrare. (7)
Generalmente l’ufficio tributi del Comune predispone appositi modelli per la denuncia dei locali ai fini TARSU.
La denuncia di occupazione va presentata entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, è unica per tutti gli immobili o le aree occupate o detenute da uno stesso soggetto nel Comune(8) ed è inoltre valida anche per gli anni successivi (a condizione che i presupposti di tassabilità rimangano invariati). Nell’eventualità in cui tali condizioni varino, il contribuente è tenuto a presentare nuova denuncia nelle medesime forme di quella iniziale. Si considera valida la denuncia di occupazione effettuata direttamente dal soggetto passivo, senza l’utilizzo dei modelli appositi, sempre che siano indicati dati essenziali quali: gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare, i dati anagrafici comprensivi di codice fiscale o partita Iva per le persone giuridiche, l’ubicazione, la superficie e l’uso dei locali e delle aree, le eventuali richieste di esclusione dalla tassazione secondo le disposizioni del regolamento, la data d’inizio dell’occupazione o detenzione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati (o dal rappresentante legale in caso di persone giuridiche). Il Comune deve rilasciare opportuna ricevuta di avvenuta presentazione (nel caso si utilizzi il mezzo postale, farà fede la data indicata sul timbro postale per il giorno di avvenuta presentazione).
La TARSU può essere ridotta sulla base dei dati contenuti nella denuncia del contribuente (iniziale, di variazione o integrativa), tuttavia l’effetto della riduzione avrà inizio nell’anno successivo alla denuncia.
Sono possibili attenuazioni tariffarie non superiori ad un terzo nei casi di: uso stagionale, limitato e discontinuo di alloggi, (comprovato nei modi previsti dalla legge e dal regolamento ai fini del riconoscimento dell’attenuazione, e riscontrato dal Comune) compresi gli alloggi a disposizione di cittadini all’estero; abitazione con unico occupante o tenuta a disposizione per uso stagionale, per uso limitato e discontinuo; soggetto passivo che risieda o abbia dimora per più di sei mesi all’anno fuori dal territorio nazionale e quindi si trova ad utilizzare l’abitazione in modo stagionale, limitato o discontinuo; locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo, muniti di licenze ed autorizzazioni per l’esercizio di attività.
La riduzione non deve essere superiore al 30% per gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale. (9)
Nel caso della cessazione dei presupposti della riduzione, il soggetto passivo deve farne denuncia entro il 20 gennaio; altrimenti il Comune provvede al recupero del tributo a partire dall’anno successivo alla denuncia che ha dato luogo alla riduzione, ed in più saranno applicate le sanzioni per omessa denuncia.
I Comuni possono, inoltre prevedere agevolazioni per le attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese d’impianti o interventi tecnici che comportano un’accertata minore produzione di rifiuti o che agevolino lo smaltimento o il recupero degli stessi. (10)
Sono disciplinate diverse cause obiettive che giustificano una riduzione della TARSU.
Le condizioni sostanziali e formali previste dalla legge per l’ottenimento di tariffe particolari sono subordinate alla dimostrazione da parte del contribuente di produrre rifiuti al di sotto della media ordinaria (fornendo quindi la prova contraria alla presunzione dell’Ente locale). Le agevolazioni generali sono suscettibili di una cosiddetta “personalizzazione” nell’ambito dell’autonomia regolamentare concessa agli Enti locali.
Vi è poi la facoltà dei Comuni di introdurre altre categorie di agevolazioni, oltre a quelle esaminate(11), sotto forma di riduzioni della tassa o, in alcuni casi, di esenzioni.
In realtà in tal caso possono sussistere dei limiti soprattutto di carattere finanziario.
Infatti, la riduzione e, in casi eccezionali, l’esenzione dovranno essere applicate in modo strettamente riduttivo, non solo perché inerenti al costo del servizio reso, ma anche perché, per motivi socio–economici, è necessario evitare ogni tipo di discrezionalità volta ad agevolare categorie di contribuenti che non rientrano in condizioni di particolare necessità a discapito di tutte quelle condizioni di disagio economico o d’interesse collettivo–ambientale.
Esclusi dalla TARSU sono: i locali e le aree che per loro natura ed uso non possono produrre rifiuti, oppure in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, le parti comuni dei condomini, salvo che siano utilizzate da un soggetto in via esclusiva, le superfici che producono, in base a lavorazioni industriali, rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori a proprie spese(12), le aree scoperte pertinenti o accessorie alle civili abitazioni diverse dalle aree verdi, (13) i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole, espressamente menzionati mediante una delibera comunale.
I casi d’esonero o esclusione dalla TARSU per la sussistenza di alcune condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o l’assetto delle superfici, sono: luoghi stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la rimozione dei rifiuti, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche, sempre che, secondo la comune esperienza, non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, locali non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, alloggi non allacciati a servizi a rete oppure superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
Le ipotesi di esclusione sono da evidenziare nella denuncia con l’onere della prova a carico del contribuente. Resta ferma la possibilità di produrre le prove anche successivamente alla denuncia ed il diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto indebitamente versato.
Si è posto il problema della tassabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai “servizi di rete” elettrica ed idrica.
La Corte di Cassazione, ha confermato che il presupposto dell’occupazione o detenzione, di locali in uso esclusivo o riservato ha carattere di presunzione della potenzialità o attitudine di produzione di rifiuti, e la normativa sancisce disposizioni che consentono di escludere con certezza, in determinate situazioni, la previgente presunzione assoluta di produzione di rifiuti, e quindi esclude l’operatività di tale presunzione con riferimento ai casi in cui si verifica un’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata. (14)
La legge esclude dall’imposizione le superfici e le aree dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. (15)
E’ pacifico che negli stessi locali o aree non si debba escludere la semplice presunzione della formazione di rifiuti urbani, unitamente a quelli speciali. Quindi l’espressione “di regola” significa “non esclusivamente”; infatti, se la formazione “di regola” di rifiuti speciali è accertata, l’esenzione della tassa sussiste nonostante il formarsi presuntivo sulla stessa area anche di rifiuti urbani.
Vige dunque l’intassabilità delle superfici dove si producono “di regola” rifiuti speciali, tranne il caso di dichiarata assimilazione di questi ai rifiuti urbani.
Una diversa scelta del legislatore avrebbe determinato una duplicazione di oneri, poiché chi produce rifiuti speciali è tenuto a provvedere allo smaltimento a propria cura e spese, e quindi è escluso dal tributo per le aree dove tali rifiuti si producono. (16)
NOTE:
(1) Cfr. F. Caroleo Grimaldi- A. Maio, “La nozione di rifiuto fra normativa comunitaria e normativa Interna” in Dir. Giuris. Agraria e Ambiente ,2004,4,2, pag. 217 e ss.
(2) Cfr. P. Gonnelli, “La normativa comunitaria sui rifiuti”,Cedam, 1996, pag. 123 e ss.
(3) Non ogni superficie privata può essere indiscriminatamente sottoposta al tributo, giacché ciò equivarrebbe alla surrettizia trasformazione della tassa in imposta (cfr. Trib. Napoli, 25 marzo 1994).
(4) Cfr G. Troise, “La denuncia e l’accertamento nella TARSU”, in Azienditalia. Finanza e Tributi, 2000, pag. 1363.
(5) Art. 63 del D.Lgs. n. 507/93.
(6) Secondo la definizione dell’art. 117 Cod. Civ.
(7) Sul punto vedi A. Spazi, “Locali ed aree non tassabili ai fini TARSU”, in Azienditalia. Finanza e Tributi, 1999, pag. 961.
(8) Si veda l’art. 70 del D.Lgs. N. 507/93.
(9) Si rinvia a L. Lovecchio, “Le riduzioni nella tassa smaltimento rifiuti”,in Trib. Loc. e Reg. 1996, pagg. 74 e ss.
(10) Cfr. L. Lovecchio, “Le riduzioni nella tassa smaltimento rifiuti”, in Trib. Loc. e Reg., 1996, pag. 76 e ss.
(11) art. 67 del D.Lgs. 507/93.
(12) Sul punto si veda A. D’Amora, “Sulla applicazione della TARSU sui rifiuti speciali e sulla natura del tributo”, in Dir. e prat. trib., 2000, II, pag. 96.
(13) Cfr R. Baggio, “Riduzioni, esclusioni ed agevolazioni nel contesto della nuova tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”, in Fin. Loc., 1995, pag. 202. Per quanto riguarda l’esclusione delle aree accessorie si veda anche V. Antelmi, “In tema di tassazione delle aree scoperte ai fini TARSU e riparto della giurisdizione tra giudice tributario e amministrativo” in Gt. Riv. Giur. Trib., 2000, pag. 75 ed anche V. Antelmi, “Applicabilità della TARSU ai locali accessori”, in G.T. Riv.Giur. Trib., 2000, pag. 1026 e dello stesso autore “TARSU e imponibilità dei locali accessori dell’ abitazione principale”, in G.T. Riv. Giur. Trib., 1999, pag. 629.
(14) Per un’analisi approfondita delle agevolazioni e delle riduzioni, si rinvia ad A. Spazi, “Le agevolazioni e le riduzioni in materia di TARSU e di tariffa rifiuti”, in Azienditalia. Finanza e tributi, 1999, pag. 1185.
(15) Art. 62 co. 3 del D.Lgs. 507/93.
(16) Cfr. Ielo G. “Fisco in pratica. Le agevolazioni nei tributi locali”, IPSOA, pagg. 13-36.
Fonte: http://www.innovazionediritto.unina.it/archivionumeri/0806s/michel.html









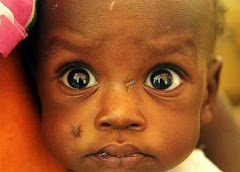









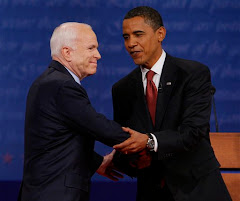









Nessun commento:
Posta un commento